38. Padania e dintorni (3)
Le manifestazioni politiche della piccola e media borghesia sulla spinta della riorganizzazione incessante del capitale
L'ascesa dei capitalismi distrettuali nelle due padanie antagoniste
Occorre parlare di due Padanie perché ogni generalizzazione sullo sviluppo del capitalismo distrettuale è indebita se non si precisa che il capitalismo locale è costretto ad assumere connotati specifici in relazione al complesso gioco di interessi di volta in volta presenti. Vi sono componenti borghesi ben assestate nelle pieghe della politica statale, mentre ve ne sono altre che proprio dalla politica statale (e dalla concorrenza degli altri borghesi) sono danneggiate. Anche se il Capitale agisce mediamente allo stesso modo su tutto un territorio nazionale o anche su tutto il pianeta, i conflitti all'interno della classe che ne rappresenta il corpo biologico non possono essere evitati. I processi di rivitalizzazione del Capitale sono univoci, ma coinvolgono parti diverse della borghesia: sono queste ultime a dare interpretazioni disparate rispetto ai processi. Fortunatamente per noi, nel capitalismo vi sono sufficienti contraddizioni per togliere valore definitivo a tutti gli espedienti rivitalizzatori, con buona pace di ogni frazione della borghesia. Marx aveva ragione, con buona pace anche di coloro che nelle altre classi e non-classi vedono la morte del comunismo e la vita eterna del capitalismo: ogni causa antagonistica alla caduta del saggio di profitto non fa che spostare le contraddizioni intrinseche del capitalismo al livello superiore e più esplosivo. In particolare, per quanto riguarda il discorso che stiamo facendo, l'esigenza di autonomia non è disgiunta dall'esigenza del controllo centrale. Nessun distretto industriale potrebbe farsi una rete infrastrutturale privata: le ferrovie, le linee ad alta tensione, le telecomunicazioni, ecc. vanno al di là della possibilità di sistemazione locale delle aree (35). Accanto alla rivendicazione di autonomia, ci sarà sempre l'accusa che lo Stato centrale non ha fatto abbastanza per soddisfare gli interessi locali. Così come accanto agli autonomisti ci saranno sempre i centralisti, cioè coloro che hanno fatto ottimi profitti proprio attraverso la distribuzione sociale del plusvalore operata dallo Stato. Semplificando, diremo che il leghismo lombardo-veneto e il centralismo democratico emiliano-sabaudo sono dialetticamente uniti e separati: uniti nella loro qualità di rappresentanti delle residue vitalità capitalistiche; separati nella loro qualità di rappresentanti degli interessi contrapposti all'interno della società. Finché si potrà godere di uno sfruttamento di forza-lavoro garantito secondo i criteri del mercato internazionale, di fronte ai quali sindacati e partiti si sentono in particolar modo responsabili, le due correnti saranno complementari; esse rappresenteranno positive differenze di un sistema dinamico e si esprimeranno attraverso la solita politica parlamentare in modo più o meno tradizionale, come stanno facendo adesso. L'una coinvolgendo selvaggiamente l'operaio nel suo proprio sfruttamento senza regole; l'altra coinvolgendolo in uno sfruttamento perfettamente regolato dal corporativismo collaborativo.
Ma la naturale e ovvia sopraffazione della corrente più debole (quella che, sempre semplificando, chiamiamo leghista) ad opera del grande capitale è in grado di combinare sconquassi sociali di portata imprevedibile: troppo grande è la moderna massificazione intorno agli strati intermedi che formano il vero e invisibile "partito trasversale", quello che più di tutti è sensibile all'esigenza di mantenere i risultati raggiunti, dato che è anche quello che più di tutti li vede minacciati (36).
Per capire il processo attraverso cui si svilupperà il meccanismo di distruzione delle riserve dello strato sociale intermedio, occorre ritornare per un momento al nostro esperimento concettuale, quello dello smembramento di una fabbrica a ciclo verticale in tante fabbriche più piccole costituite dagli ex reparti di produzione. Ciò è necessario perché, contrariamente a ciò che potrebbe sembrare a prima vista, il processo di diffusione industriale non fa aumentare il numero reale delle imprese ma lo fa diminuire; non avvantaggia i capitalisti ma li espropria; non produce più posti di lavoro ma li distrugge; non produce più accumulazione ma la limita. Ne risulta che ogni società chiusa dentro le sue obsolete frontiere diventa sempre più dipendente dal Capitale e sempre più impotente a controllare gli effetti dei suoi movimenti mondiali.
Nel nostro modellino avevamo visto che invece di una grande fabbrica che produce una singola merce, abbiamo ora tante fabbriche autonome che producono tante merci. Le quali vengono scambiate in quanto tali e non più in quanto prodotti interni al ciclo di lavorazione. Prima questi prodotti interni erano conteggiati in quantità fisiche e il loro valore era indifferente, dato che l'unica cosa importante era il valore finale del prodotto tipico di quella fabbrica. Ora le singole merci prodotte autonomamente sono messe assieme dopo essere state immesse sul mercato e solo dopo daranno luogo al prodotto finale di prima. Se le cose si fermassero qui non vi sarebbe nessun vantaggio dal punto di vista dello sviluppo del lavoro sociale, anzi, avremmo fatto un passo indietro nella storia, verso il capitale mercantile o, come dice Marx, commerciale, dove il lavoro specifico rimane ancora un valore legato ad un prodotto che non è ancora compiutamente merce, dove la separazione tra gli elementi della riproduzione sociale non è ancora perfetta.
Caduta tendenziale delle classi superflue
Nel nostro caso, il vantaggio dell'operazione di scorporamento delle unità produttive interne in unità produttive autonome sta esclusivamente in due punti che permettono a questo piccolo sistema di non rappresentare un regresso rispetto alla storia del capitalismo, ma di avanzare grandemente. Come già accennato essi sono:
1) autonomia di ogni unità produttiva, ma rigorosamente all'interno di un sistema centralizzato che, come succedeva quando essa era reparto facente parte di un flusso produttivo generale, ne assorbe i prodotti secondo un piano. Come nella situazione precedente, non si perde il vantaggio di accedere a strutture e servizi comuni, vantaggio che rappresentò la base rivoluzionaria della manifattura ai suoi albori (37). Oggi si usa il termine "sinergia" per dare un nome nuovo ad un vecchio fenomeno ben conosciuto dal marxismo;
2) utilizzo pieno delle risorse (uomini, macchine, processi) non solo per la produzione della casa-madre, ma per chiunque abbia bisogno di quel tipo di merce. Abbiamo già visto che ciò aumenta la possibilità di ingrandire la scala della produzione, diminuire i costi unitari, partecipare al meglio al confronto col saggio di profitto medio generale, passare a nuove tecnologie e a nuovi processi, rivolgersi al mercato estero, ecc.
Tutto ciò va sotto il nome generico di aumento della produttività. Sotto questa definizione viene ammucchiato un po' di tutto, ma dal punto di vista marxista il significato è uno solo e si esprime in tre termini: aumento del saggio di sfruttamento; eliminazione di capitalisti; eliminazione di tempo di lavoro. Ma com'è possibile, si dirà, che aumentino le fabbriche e diminuiscano i capitalisti? Tutti capiscono che l'automazione e i moderni processi eliminano forza-lavoro, ma non tutti forse ritengono così evidente che un numero maggiore di fabbriche possa corrispondere ad un numero inferiore di capitalisti.
Eppure il signor Benetton possiede uno stabilimento solo e pochi negozi, ma controlla decine di fabbriche e migliaia di punti di vendita in tutto il mondo. In tal modo i capitalisti che lavorano per lui sono dei semplici funzionari della holding e i negozianti che hanno un contratto in franchising sono dei semplici commessi. Il signor Benetton risparmia una quantità enorme di capitale costante e i partner rinunciano alla loro qualità di capitalisti in cambio dell'inserimento nel gruppo. E' ovvio che ci guadagnano entrambi, ma i secondi sono spariti come capitalisti veri e propri.
Se l'esempio del settore abbigliamento sembra un po' leggero, passiamo a qualcosa di veramente pesante. Il settore della componentistica auto può essere un campo altrettanto esemplare per l'osservazione per quanto andiamo dicendo. Esso è concentrato in quattro regioni: Piemonte (46% del fatturato), Lombardia (37%), Emilia-Romagna (4%), Veneto (3,5%). Il restante 9,5% è sparso al Centro-Nord, mentre le fabbriche automobilistiche al Sud non hanno comportato la nascita di un indotto. La componentistica auto, passando dal rapporto diretto con i costruttori (in pratica solo la Fiat) alla concentrazione e alla centralizzazione, ha conosciuto non solo un aumento della scala della produzione, ma soprattutto è passata da un rapporto subordinato con il cliente unico ad una presenza sul mercato internazionale. L'esportazione del comparto è infatti ragguardevole, raggiungendo il 40% della sua produzione globale e il 3,8% delle esportazioni totali italiane. Il passaggio dal legame quasi esclusivo con la casa costruttrice alla produzione per il mercato mondiale è stato piuttosto veloce, circa dieci anni. Oggi le aziende produttrici di componenti automobilistici devono seguire il destino dei costruttori d'auto, diventare internazionali e assumere dunque
"la capacità di essere a loro volta globali, cioè in grado di produrre e far produrre i propri componenti nei paesi di nuova localizzazione degli impianti dei costruttori, creando all'uopo fabbriche ex novo, joint venture o rapporti di collaborazione industriale con aziende locali. L'effetto sulla struttura del comparto è un aumento del livello di concentrazione conseguente al rafforzamento dei rapporti con i fornitori che sono già globali o che danno garanzia di diventarlo. Spinge verso una più accentuata concentrazione la tendenza dei costruttori ad acquistare sub-sistemi o insiemi di componenti già assemblati, processo che gioca a favore di quei fornitori che sono in grado di dominare le tecnologie prevalenti nei sub-sistemi o insiemi e coordinare le forniture" (38).
Inutile dire che i fornitori strategici di componenti sono controllati, nel senso di una partecipazione azionaria significativa, dalle case costruttrici. La Fiat per esempio controlla a maggioranza il 18% dei suoi fornitori, ma ha partecipazioni in quasi tutti i maggiori. Si giunge così al paradosso che alcune grandi industrie, controllando la proprietà di fornitori che producono a monte non solo per loro, ma per il mercato mondiale, producono non solo per sé ma anche per i propri concorrenti.
Questi esempi ci mostrano uno stadio attraverso il quale il capitalismo passa necessariamente. In un primo tempo il processo è doloroso e spontaneo, dato che il riassetto segue i movimenti anarchici del mercato. Una volta capito di che si tratta, il processo diventa parte integrante delle politiche aziendali, quindi impostato preventivamente secondo progetti industriali. In certi casi, sempre più frequenti, tale processo entra a far parte della politica economica degli Stati. Si dice in uno studio sulla ristrutturazione storica del distretto tessile pratese avvenuta negli anni '70:
"La sindrome da decentramento è una malattia che si contrae quando si scoprono le opportunità e le scappatoie (c'è chi parla di punti di minore resistenza) che esso può offrire: da quel momento in poi, acriticamente e pedestremente, diventa regola inamovibile. Ma c'è un processo successivo, che partendo dal fenomeno decentramento ed apprezzati alcuni suoi connotati ne ridisegna progressivamente i contenuti e ne modifica gli obiettivi. Questi processi nati con l'intento di reagire alla crisi, di diminuire la presa del sindacato, di sfruttare differenziali salariali ecc. subiscono col tempo delle trasformazioni quando casualmente si scopre che i risultati acquisibili sono anche, e forse soprattutto, altri [...] Emergono altre motivazioni quali la flessibilità organizzativa, la semplificazione dei sistemi di gestione, gli apporti di professionalità differenziata delle imprese terziste. Un ultimo punto da sottolineare concerne la natura dei prodotti. La presenza di una gamma merceologica che muta rapidamente determina impulsi e ordini di produzione con caratteri di forte rotazione; la differenza con produzioni standardizzate e ripetitive è sostanziale. L'incremento di valore aggiunto riscontrabile nei prodotti in possesso di detti connotati sposta i termini del fenomeno così come la natura delle relazioni fra imprese. [...] I pratesi riescono a produrre in tempi più brevi di altri qualunque articolo venga commissionato anche partendo da ordini nuovi e non da riassortimenti" (39).
Economia e "massa critica"
Qui il "decentramento" è ovviamente inteso come ristrutturazione generale di un intero settore produttivo datato, cambiamento che porta ad una redistribuzione sul territorio delle lavorazioni dopo le classiche misure di ridimensionamento o addirittura chiusura di industrie, i licenziamenti e gli iter lunghissimi di cassa integrazione e mobilità contrattate nella co-gestione sindacale e statale del sistema ammortizzato. Tale ristrutturazione generale rappresenta una frustata d'energia al sistema locale, il quale affronta un nuovo ciclo di accumulazione sulla base di nuovi investimenti. La fonte di questi ultimi è sempre meno l'autofinanziamento (in Italia il ricorso alla Borsa è praticamente inesistente per la stragrande maggioranza delle imprese) e sempre più il credito bancario, perciò il nuovo ciclo sarà caratterizzato da alto profitto ma anche da alto capitale anticipato, che significa basso saggio di profitto. Quest'ultimo sarà compensato da una accresciuta massa e, come dice Marx, non è ancora nato il capitalista che preferisca il 10% su 1.000 piuttosto che il 2% su 10.000. Per questo sarà fregato dalla storia: è qui che il grosso gode e il piccolo crepa.
Nella discussione sull'unità europea e sulla concorrenza internazionale è spesso ricordato il concetto di massa critica economica, termine preso a prestito dalla fisica termonucleare la quale a sua volta l'aveva preso a prestito (attraverso Von Clausevitz ma il concetto è utilizzato anche da Engels) dal lessico militare. La massa critica economica per un mercato unitario ritenuto in grado di fronteggiare l'America e il Giappone è di una quarantina di milioni di famiglie consumatrici. Ciò costituirebbe un mercato interno europeo sufficiente per avviare un processo produttivo integrato di merci il cui rapporto costo-qualità sia in grado di opporsi alla tendenza esportatrice netta soprattutto dell'Asia. Questo aspetto è particolarmente sentito da coloro che già sono esportatori netti, ma che nel caso di integrazione europea rientrerebbero nella media e perderebbero tale primato. Inutile dire che l'unico paese europeo esportatore netto costante è sempre stato la Germania (adesso ci sono anche l'Olanda e la Padania). Sulla carta la massa critica che doveva formare il nocciolo duro (carolingio) dell'integrazione europea era costituita da Francia e Germania, ma la Francia è un importatore netto e tutto è saltato.
Il concetto di massa critica può essere utilizzato in modo corretto anche dal punto di vista marxista anche se è trattato dai borghesi in modo molto indeterminato. Che cosa significa infatti "massa critica economica"? Per i borghesi si tratta, in ultima analisi, della produzione e della possibilità di assorbimento dei prodotti in un dato mercato omogeneo. L'aspetto quantitativo e qualitativo delle merci si dovrebbe cioè imporre sul mercato mondiale in assoluta concorrenza, in virtù del fatto che sono già prodotte in larga scala per l'interno.
Il ragionamento è questo: complessivamente l'Europa ha un potenziale economico di gran lunga superiore sia agli Stati Uniti che al Giappone; ma mentre ognuno di essi ha un'economia unica, quella dell'Europa deriva dalla semplice somma di economie indipendenti e in contrasto fra loro. Passando attraverso l'integrazione monetaria, si dovrebbe giungere a quella economica e sociale in grado di reggere la concorrenza con una massa critica omogenea da contrapporre a quelle concorrenti. Ciò non ha nulla a che vedere con una specifica unità territoriale. Nell'epoca della dominazione reale del Capitale, vale a dire dell'uso contemporaneo di plusvalore relativo (ovvero maturità) e di plusvalore assoluto (ovvero controtendenza alla caduta del saggio di profitto, senescenza) da parte di uno stesso soggetto produttivo-finanziario in diverse aree del globo (ovvero globalizzazione), la massa critica non è più costituita da un singolo Stato o da un assemblaggio di Stati che funzioni come ogni singolo Stato precedente. La massa critica è rappresentata da aree anche distanti fra loro ma che formano un aggregato unitario di volta in volta riconosciuto dal Capitale in cerca di valorizzazione. Possono essere Stati o meno, insiemi stabili e integrati o evanescenti e poco strutturati; sta di fatto che nessuno, da che il Capitale si è reso autonomo dai capitalisti, è mai riuscito a prevederne in anticipo la funzione. Da questo punto di vista l'Unione Europea intesa come unione territoriale è ininfluente, perché la tendenza generale, nella cosiddetta globalizzazione, è quella della fissazione temporanea del Capitale su aree determinate specie là dove il controllo statale si limita ad un assecondamento delle esigenze dell'intero sistema capitalistico. La globalizzazione, da questo punto di vista, è assolutamente il contrario di quanto si vorrebbe far credere: è un processo che porta non all'unificazione dei territori produttivi ma alla loro frammentazione, fenomeno per il quale sono stati coniati termini più o meno azzeccati, come "balcanizzazione economica", "arcipelaghi industriali" o, altro termine militare, "diffusione a macchie di leopardo". Ciò che conta dunque non è il colore uniforme sulla cartina geografica ma la rete dei rapporti e il controllo esercitato su larga scala da parte di poche concentrazioni di capitale. In ultima analisi la massa critica economica si può definire, da parte nostra, come sistema "locale" di riproduzione del capitale, in grado non solo di accumulare in proprio ma di rappresentare un attrattore di capitali altrui, in modo da resistere alla concorrenza e non essere spazzato via dalle necessarie e ricorrenti crisi. Un sistema locale può essere un distretto industriale o anche un intero continente. Ma gli Stati e i continenti coalizzati possono ricorrere a politiche governative di difesa, i distretti industriali no. I comprensori di più recente sviluppo, essendosi formati sull'onda del movimento generale del Capitale, sono i più soggetti anche a subire il processo inverso, cioè a esserne abbandonati. Di qui la loro estrema sensibilità verso ogni agente esterno che abbia il potenziale per minacciarli o anche solo per mettere in discussione i risultati raggiunti (40).
Le forze leghiste di ogni sfumatura non sono che il prodotto inconsapevole di tutto ciò, e le loro teorizzazioni, non giungendo alla comprensione del fenomeno, si riducono ad un ritorno verso modelli medioevali, nei quali non esisteva la politica economica coordinatrice dello Stato e la difesa territoriale si accompagnava alla federazione mercantile con altri distretti produttivi. Chissà se l'oscuro inventore del primo simbolo leghista sapeva che Alberto da Giussano era nemico delle autonomie feudali e lottava per un antenato degli stati moderni!
Avveniristici robot e antica schiavitù salariata
Per i marxisti la vera massa critica è la massa del plusvalore, indipendentemente da dove e come essa venga prodotta e utilizzata: chi di volta in volta potesse mettere sotto controllo una massa di plusvalore più grande di altri potrebbe controllare totalmente i cosiddetti mercati. Ogni singola merce si confronta col valore medio di tutte le merci simili e la spunta sul mercato solo se il suo proprio valore è uguale o inferiore a quello medio, così da garantire al capitalista un saggio di profitto che vada dalla media in su. Ma, nel confronto fra sistemi produttivi che gettano sul mercato montagne di merci, è evidente che un centro di controllo capitalistico che fosse in grado di maneggiare una grande massa di plusvalore (passato e futuro) in concorrenza con altri che ne maneggiassero una piccola, sarebbe destinato a vincere sul campo indipendentemente dal saggio di profitto individuale ottenuto. Questo perché, come Marx ci insegna, dato che il valore della forza-lavoro e un certo saggio di sfruttamento si equivalgono all'interno di sistemi economici in grado di competere fra loro, l'unico modo per aumentare la massa del plusvalore sarebbe quello di aumentare il numero degli operai per aumentare così il numero delle merci prodotte. Ciò sarebbe naturalmente in antitesi con l'ammodernamento dei processi produttivi, con la tendenza storica all'aumento del saggio di sfruttamento e alla diminuzione del numero di operai in rapporto al capitale complessivo da questi messo in movimento. Sarebbe in antitesi con la tendenza storica generale, ma non con la realizzazione in aree specifiche delle condizioni adatte per lo sfruttamento intensivo ed estensivo della forza-lavoro, dove la modernità assoluta si accompagna spesso alla schiavizzazione di intere popolazioni, compresi vecchi, donne e bambini. E non è detto che ciò avvenga solo e sempre nel cosiddetto Terzo mondo.
I grandi sistemi economici, quindi, che siano costituiti da capitalisti privati o che siano un'espressione pubblica o anche nazionale, sono costretti a oscillare fra l'estorsione di plusvalore relativo (macchinismo, automazione, organizzazione, ecc.) e l'estorsione di plusvalore assoluto (aumento del numero di operai, abbassamento del salario, allungamento della giornata lavorativa). Sono costretti perciò ad utilizzare su territori diversi le condizioni adatte per il raggiungimento del massimo risultato, oppure adattarsi in tempi diversi alle condizioni imposte dalla contingenza. Avremo così aziende (o sistemi economici più vasti) che nel breve volgere di anni possono passare da cicli di estorsione di plusvalore relativo a cicli di estorsione di plusvalore assoluto e viceversa, con variazioni sostanziali anche nella loro struttura produttiva. Ad esempio il calzaturificio De Fonseca ha abbandonato la produzione nazionale ad alta composizione organica di capitale (automazione) per insediarsi in Cina, dove ha aperto sei stabilimenti a bassa composizione organica di capitale (manifattura tradizionale con 60.000 dipendenti), in cui produce decine di milioni di calzature che esporta in tutto il mondo. Al contrario, l'industria di confezioni del solito Benetton, ha fatto rientrare tutte le lavorazioni dai paesi in via di sviluppo e le ha concentrate in un supercomputerizzato stabilimento in Italia, da dove le merci vengono spedite in migliaia di negozi in franchising sparsi sul pianeta (41). In questo modo non ha solo risparmiato sul profitto da dare al fornitore, ma ha impiantato un immenso sistema di vendita che ricava profitto anche dall'attività commerciale del singolo negozio, dato che ha trasformato il negoziante in un suo subordinato, inserendolo in un planetario supermercato diffuso dell'abbigliamento.
La Fiat ha licenziato decine di migliaia di lavoratori in seguito alla riorganizzazione del gruppo sulla base di un'alta composizione organica iniziata nella metà degli anni '70, passando da 200.000 a 120.000 dipendenti in dieci anni. Ma nei successivi dieci ha superato i 240.000 dipendenti distribuendo la produzione in aree del mondo a basso costo della manodopera. Così nella sola area torinese i dipendenti sono passati da 120.000 a 40.000 e in Italia è previsto che rimarranno attive solo le linee dei prodotti nuovi o non di massa "ad alto valore aggiunto", come le vetture di fascia alta, i mezzi di produzione e i componenti aerospaziali.
Se ai fini dell'aumento della massa del plusvalore è necessario, a parità di saggio di sfruttamento, aumentare il numero degli occupati, è evidente che il massimo risultato possibile sarebbe quello di ottenere, sullo stesso territorio e all'interno dello stesso sistema economico, sia un aumento del numero degli occupati che un aumento del saggio di sfruttamento. Può sembrare una banalità ma non lo è. Ogni aumento del saggio di sfruttamento si traduce, storicamente, in una diminuzione degli occupati in rapporto alle quantità prodotte. Inoltre vi sono dei corollari non meno contraddittori: in primo luogo l'aumento del numero degli occupati provoca per definizione una diminuzione di concorrenza fra la forza-lavoro e quindi un aumento del salario (cioè una diminuzione del saggio di sfruttamento); in secondo luogo l'aumento del saggio di sfruttamento in un sistema che fa parte del mercato e che quindi si avvicina alla media, è solo possibile con un aumento della giornata lavorativa, e ciò si può ottenere solo infrangendo le regole vigenti quando non anche le leggi dello Stato. Il fatto non banale è che nessun capitalista da solo potrebbe giungere a tanto. Occorre un ambiente sociale adatto. E' quindi necessario sia un controllo sociale della manodopera, nel caso che questa tenda a ribellarsi, sia un coinvolgimento della stessa manodopera nel processo produttivo del sistema, poiché i fenomeni ricorrenti e normali di ristrutturazione capitalistica possono effettivamente produrre benefici ad un capitalismo asfittico solo se il proletariato è partecipe in massimo grado al suo proprio sfruttamento. Attraverso questi meccanismi, come anche attraverso il rincoglionimento derivato dalla rinuncia a tempo di vita per sé, una parte del proletariato acquisisce delle riserve (casa, risparmio, beni durevoli) ed è coinvolto nella salvaguardia di ciò che esiste, assumendo anche, come ben fecero notare sia Marx che Lenin, l'ideologia conseguente. Non essendo possibile per il proletario atteggiarsi a borghese, egli si adatta a scimmiottare le non-classi. Ma le sue riserve non sono sostanziose come quelle del bottegaio o del professionista, né egli può avere voce in capitolo fuori dalla lotta di classe: da vero colcosiano industriale egli si ridurrà a far la vita peggiore di tutti. Non sarà schiacciato fra la "famiglia, il cortile e i polli" come il suo omologo agricolo russo, ma fra la famiglia, il pianerottolo e la fabbrica dove la parte del pollo d'allevamento sarà impersonata da lui stesso. E questa è una condizione più miserabile di quella descritta da Lenin per l'aristocrazia operaia su cui cadevano le briciole del banchetto imperialista. Almeno quella era pagata bene.
Fame di plusvalore assoluto e relativo
Ora, a proposito delle isole felici del tessile ristrutturato, dei Benetton mondializzati ecc, nel Nord-Est è impiegato quasi un quarto della forza-lavoro italiana del settore tessile (più della metà è impiegata nel Nord-Ovest e un altro quarto nel resto del paese). Fatto 100 il salario dell’operaio del Sud, il più basso, segue il Nord-Est con 103 (Treviso e Padova sono al livello più basso), le isole con 106, il Nord-Ovest con 111, il Centro con 117 (qui Prato ha il salario massimo, Carpi il minimo). Quindi l'operaio triveneto è pagato peggio di tutti, tenendo conto che nel Nord-Est si fanno otto ore medie di straordinario alla settimana (42). Morale: la macchina asservisce l’uomo, e l’estorsione di plusvalore relativo non impedisce il ricorso, sullo stesso operaio, all’estorsione di plusvalore assoluto.
In Italia i distretti più caratterizzati nascono quasi tutti intorno a produzioni specifiche via via allargate e integrate, specialmente a partire dal tessile. Attraverso veri processi di imbarbarimento industriale neocolcosiano, negli stessi anni in cui tramontava per sempre la potenza tessile dei distretti inglesi con in testa lo Yorkshire, quelli italiani si mettevano in grado di competere con i concorrenti dei paesi di recente capitalismo. Dato che la potenza tessile nostrana non era neppure paragonabile a quella inglese, il suo successo non può essere cercato soltanto nel tramonto dell'antico rivale ma nella capacità di far fronte a quelli nuovi. Non esiste sociologia del territorio che tenga: la concorrenza si vince sul piano del plusvalore estorto, e nei distretti italiani, tessili o no, il successo si è misurato in capacità di sfruttamento e autosfruttamento.
Il territorio di Carpi, per esempio, rappresenta il classico passaggio dall'autosfruttamento artigianale e casalingo per la fornitura unica verso poche industrie o verso il racket dei "magliari", all'industria specializzata e moderna, fornitrice di semilavorati anche a terzi, in grado di massimizzare il saggio di plusvalore. In una decina d'anni esso si trasforma, da zona semi-agricola intorno al solito paesone centro di mercato, in area industriale tessile raggruppata intorno ad una città; diventa un sistema integrato locale in grado di esportare la quasi totalità della sua produzione. In un altro decennio, grazie all'accumulazione dovuta al tessile, a Carpi si amplia la base produttiva con il piccolo boom locale dell'industria metalmeccanica e della plastica, anch'essa largamente esportatrice.
Anche il distretto tessile di Prato, storicamente cresciuto fin dal Medioevo sulla raccolta di stracci da cardare, fu in competizione con i superiori distretti inglesi fino a tempi recenti. Ma la sua debolezza strutturale fu anche in questo caso un elemento di sopravvivenza, perché lo costrinse ad avere maggiore dinamicità e intraprendenza. Prato ha conosciuto in anticipo uno sviluppo simile a quello di Carpi e del Veneto, ma ancora più eclatante dal punto di vista della concentrazione e di un sistema produttivo che è andato ben oltre l'indotto, il lavoro artigianale e quello a domicilio. Prato è diventata l'esempio della fornitura tessile ad hoc, fino alla estrema specializzazione mirata sul singolo cliente. Intorno al 1900 l'area cittadina non si era ancora sviluppata fuori dalle mura medioevali, ma già nel primo anteguerra l'antico artigianato tessile era industria; povera, ma industria. Il boom venne dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche qui grazie ad una integrazione produttiva dell'intero comprensorio tessile, cui si affiancarono la chimica dei coloranti, la meccanica delle tessitrici automatiche, la confezione di calzature e, via via, una serie di industrie sempre più diversificate fino a caratterizzare il distretto non più come semplicemente tessile ma come unità sistemica per il raggiungimento del massimo saggio di plusvalore.
Idem per il Biellese, che vanta tradizioni tessili documentate dall'epoca dei Celti, poi ben sviluppate dopo la conquista romana. Il biellese decadde all'epoca dell'esplosione tessile inglese, si risollevò grazie all'importazione delle macchine più moderne alla fine del '700, decadde nuovamente nel secondo dopoguerra a causa della concorrenza estera, si risollevò un'altra volta dopo l'alluvione del '68. Il disastro distrusse centinaia di fabbriche (80 importanti) e dimezzò gli occupati nel settore. La ristrutturazione generale e i capitali statali portarono però allo sviluppo di altre attività e vi fu un aumento della popolazione attiva. Nel biellese come in tutti i distretti di "successo", le otto ore non si sa neppure cosa siano.
La Brianza aveva un'antica tradizione artigiana del mobile che nel dopoguerra si è trasformata in industria moderna e che, gravitando sul mercato di Milano all'inizio, ora esporta in tutto il mondo. Anche in questo caso una produzione specifica si è legata ad altre antiche e tradizionali come la piccola metallurgia e la meccanica. Il modello di accumulazione brianzolo è abbastanza classico.
Nel Friuli-Venezia Giulia un disastro naturale ha favorito il rinnovamento degli impianti, sia in modo diretto (distruzione) sia in modo indiretto (incentivi alla ricostruzione). Prima del terremoto vi erano 19.000 aziende censite, di cui solo 23 superavano i 500 dipendenti e solo 10 i 1.000 (l'86% era sotto i 10). Poi arrivarono i capitali del dopo-terremoto (5.000 miliardi in stanziamenti diretti e 13.000 in sovvenzioni articolate). Vi fu uno sviluppo rapidissimo della piccola e media industria sotto l'egida delle banche locali coordinate tramite la regione autonoma a statuto speciale. In Friuli vi è una concentrazione di capitale limitata, ma in compenso vi è un'alta dinamicità industriale dovuta ad un livello elevato di esportazioni. Soprattutto si tratta di industria ad alta tecnologia, non tanto perché vi siano imprenditori particolarmente moderni, ma perché sono arrivati tardi sul mercato. Qualche anno fa, nella grande industria del triangolo lombardo-ligure-piemontese, era consueto sentir parlare del Friuli come di una Taiwan nostrana, con riferimento all'alta tecnologia utilizzata nei processi e alla disponibilità di manodopera a basso prezzo nella vicina Slovenia (di nuovo un cocktail ad altissimo saggio di plusvalore).
Vi sono naturalmente altre Padanie che rivelano tendenze all'autonomia: alcune si sono sviluppate intorno a tradizioni antiche, come il territorio bresciano che dal medioevo produce armi e che successivamente ha visto nell'acciaio il perno propulsore di un'economia ricca; altre si sono sviluppate recentemente, come il varesotto, dove l'industria si è insediata solo dopo la costruzione delle centrali idroelettriche e della ferrovia (Varese aveva 12.000 abitanti nel 1900; giunse a 40.000 nel 1930, oggi ne ha circa centomila), elementi che hanno consentito un sistema industriale immediatamente diversificato.
Non tutte le Leghe sono bossiane
Ma al di là delle specifiche storie dello sviluppo locale, e degli interessi comuni a tutti i capitalisti grandi e piccoli, quello che ci fa parlare di due padanie è una caratteristica che divide il campo in due parti nettamente distinte: una ostile allo Stato centrale, di cui abbiamo incominciato a parlare, l'altra legata strettamente ad esso. Quest'ultima è scaturita dallo sviluppo capillare del sistema corporativo vigente a partire dagli anni '20 e si è rinforzata attraverso l'apparato democratico resistenziale consolidatosi dopo la guerra. Quest'altra Padania, statalista e localista allo stesso tempo, ha interessi completamente contrastanti rispetto a quelli della sorella autonomista e ruspante. Anch'essa sente minacciata la propria solidità, costruita da quasi ottant'anni su di un rituale fisso che vede tre classici protagonisti dediti all'estorsione di plusvalore nella concertazione sociale: Stato, Industria e Sindacato; ma la sente minacciata dal venir meno dei consolidati legami. I pilastri della grande industria del vecchio "triangolo" nordista Genova-Milano-Torino si sono internazionalizzati e i legami politici con lo Stato centrale non possono più essere quelli di una volta. Anche gli interessi intrecciati con il mondo bancario sono oggi meno granitici, per il semplice fatto che anche gli interessi finanziari si sono internazionalizzati e le banche hanno dovuto correre ai ripari, fondendosi, snellendosi, potenziandosi. Questa Padania centralista e localista si sente orfana, non è né carne né pesce e il suo disagio sfocerà in qualche fenomeno politico, come sembra anticipare un certo federalismo nazionalista e soprattutto quello strano movimento socialeggiante e per ora informe che è il "partito dei sindaci".
Gli interessi corporativi che fecero la storia del triangolo industriale coinvolgono dunque anche buona parte del territorio che sta a Sud del Po e sul quale è cresciuto un tessuto industriale importante. Senza tracciare confini arbitrari, possiamo identificare quest'area grosso modo con l'Emilia-Romagna, alcune propaggini più a Sud, e mettervi Bologna come capitale. Negli ultimi 20 anni lo sviluppo capitalistico di quest'area ha visto un netto declino dell'industria a favore di un'esplosione, senza pari in Italia, dei servizi, specie quelli cosiddetti avanzati. L'80% della popolazione attiva risulta addetta a questo settore (43) e il sistema delle cooperative, che sono industrie come le altre ma solo con statuto diverso, va visto come sviluppo sociale del corporativismo sindacale di fabbrica. L'intero sistema "emiliano" è funzionale al capitalismo ultramaturo che deve "socializzare" sempre di più molte funzioni utili alla sua sopravvivenza, come ormai anche gli economisti borghesi riconoscono (44). Questo è il volto del capitalismo padano rosé, che reinveste totalmente il plusvalore, che totalmente poggia sulla collaborazione di classe, che avrà bisogno in prospettiva di un legame sempre più vitale con lo Stato, che ha già sfruttato fino in fondo le possibilità di autonomia offerte dal nuovo ordinamento regionale e che dovrà imparentarsi ancora di più con gli organismi politici centrali. E' il capitalismo di quella Padania alleata naturale dei grandi gruppi industrial-finanziari legati strettamente all'apparato statale e politico, la stessa Padania alleata naturale anche delle rappresentanze politiche del corporativismo, finite a discutere intorno a quel mercato delle vacche chiamato bicamerale e fieramente avversato dalla Padania ruspante di Bossi.
Banale ascesa del capitalismo triveneto
A differenza dell'Emilia, del Piemonte e di gran parte della Lombardia, il Veneto è più sensibile alle istanze autonomistiche e scissioniste. Ciò è dovuto al fatto che il processo di industrializzazione recente, pur innestandosi sullo strato storico del tessile di Schio, di Thiene, di Valdagno e sulle precedenti isole di accumulazione in altri settori come Mestre, Marghera, Treviso, Verona, Castelfranco ecc., si è scontrato con il processo di integrazione dell'economia italiana nell'economia europea e mondiale. Non ci sono più i margini di manovra per una benevola tolleranza verso un utilizzo locale di plusvalore, come ai tempi delle lobby venete all'interno della Democrazia Cristiana; peggio che mai per un trasferimento di plusvalore, come pure era avvenuto negli anni passati, verso aree considerate "depresse", o com'era avvenuto per lo sviluppo di infrastrutture moderne a spese dello Stato (45).
Nella maggior parte dei distretti industriali veneti il processo di accumulazione è stato classico, a partire da poche industrie ben radicate sul territorio, dalla creazione di attività indotte o collegate, fino alla successiva autonomizzazione delle aziende nel frattempo ingranditesi a spese di altre o grazie al funzionamento in simbiosi con un sistema di lavori autonomi semi-artigianali. Questi processi compositi sono stati spontanei, come negli esempi citati di Carpi e Prato, ma sono venuti dopo e quindi sono più moderni. Anche il processo di terziarizzazione di Bologna è modernissimo, ma nel Veneto non è mai esistita quella tradizione di corporativismo delle amministrazioni locali che là aveva prodotto una più efficiente allocazione delle risorse a favore di nuove tecnologie e di servizi moderni; vi è stato invece uno sviluppo prevalentemente industriale perché la piccola e media impresa non necessitano all'inizio di conoscenza tecnica particolare, finché lavorano su prodotti e commesse le cui caratteristiche specifiche vengono dettate dall'esterno. D'altra parte in Veneto si scontrava il moderno con l'arcaico: l'accumulazione industriale era in gran parte basata sulla rendita confluita nelle banche locali, rendita che aveva avuto origine addirittura dalle grandi proprietà agrarie fondate all'epoca della Serenissima dalle famiglie di mercanti diventati nobili.
Il legame delle amministrazioni del Veneto con lo Stato centrale era di tipo particolare, assolutamente diretto: si trattava di un serbatoio elettorale che non aveva bisogno di speciale attenzione per l'allocazione delle risorse, dato che i canali erano immediatamente politici. Contrariamente a quanto afferma il piagnisteo campanilistico, il Veneto è stato così poco dimenticato dallo Stato che fu persino oggetto di incentivi massicci per lo sviluppo delle "aree periurbane" dichiarate, più o meno coerentemente, "sottosviluppate" alla stregua di altre aree come il Polesine.
In realtà il Veneto non si è sviluppato tanto recentemente come vorrebbe far credere la moda del boom del Nordest sponsorizzata dai locali, e neppure vi è stata una vera e propria "esplosione" economica a partire da una tabula rasa (46). La tradizione industriale veneta, specialmente tessile, data dal secolo scorso e l'industria ha avuto, più che altrove, l'apporto di manodopera proveniente dalla disgregazione della microazienda contadina, la quale, peraltro, ha intascato ugualmente i contributi statali per la miglioria dei fondi e per la meccanizzazione. Tale manodopera ha potuto contare quindi sull'autoalimentazione per un lungo periodo ed è stata in grado di sopportare sia salari inferiori rispetto alla media nazionale che una distribuzione capillare di lavori a domicilio fuori da ogni controllo. Questi ultimi, numerosi com'erano, hanno avuto la possibilità statistica di evolvere verso l'artigianato e l'industria, con l'abbandono di coloro che guadagnavano troppo poco e la concentrazione dei sopravvissuti, che hanno così potuto fare il salto dall'autosfruttamento alla produzione capitalistica di plusvalore.
Il capitalismo verdastro leghista, con tutta la sua anarchia da giungla, si dimostra altrettanto efficiente e aggressivo di quello che abbiamo definito consociativo, rosé (47). Il Veneto, come altri serbatoi di spinte centrifughe, non si sviluppa quindi con peculiarità eccessive rispetto a tanti altri esempi che si possono fare. Il capitale era preesistente al recente slancio economico e, come al solito, ci si guadagna ad arrivare ultimi alla "ristrutturazione". Il fatto di arrivare tardi ad una sistemazione capitalistica moderna su di un particolare territorio dovrebbe spiegare di per sé l'effetto dinamico che ciò comporta. Si realizzano circostanze favorevoli simili a quelle che si verificano, fatte le dovute proporzioni, nelle aree di sviluppo asiatico, dove l'esempio più calzante è rappresentato dai nuovi distretti cinesi, sorti intorno ai vecchi centri commerciali e industriali di Canton, Pechino e Shanghai. La differenza è che in Cina, come nelle vecchie aree di Torino o Milano ristrutturate secondo piani d'intervento congiunto tra enti pubblici e privati, il processo non è semi-spontaneo ma pilotato. Abbiamo così una tipica situazione, modernissima, dove in un certo territorio si viene a sviluppare un tessuto industriale costituito da aziende (grandi, medie e piccole), che formano tra loro una rete di relazioni complementari. Le piccole aziende, e anche le medie, partecipano a produzioni complete assorbite dalle grandi, come se fossero reparti delle stesse. Ma tutte sono autonome: oltre a lavorare per un committente locale o due, lavorano anche, e a volte di più, per il mercato nazionale ed estero. La loro scala di produzione aumenta, il prezzo delle loro merci diventa competitivo in rapporto alla qualità, conquistano mercati lontani. Non è un "miracolo economico": è così perché questa è la tendenza storica del Capitale.
La socializzazione del lavoro raggiunge il massimo, così la separazione reale tra il lavoro sociale e l'appropriazione privata; così anche il conflitto fra la produzione "ordinata" secondo un piano non scritto e l'anarchia delle restanti zone del paese che non rispondono a questi requisiti e che vengono sentite come un peso morto, coordinato nelle sue componenti parassitarie dall'odiata "Roma ladrona".
Intanto Roma, per quanto ladrona, ha però eliminato la Cassa per il Mezzogiorno e la sta rimpiazzando con qualche ente più efficiente affinché la ripartizione sociale del plusvalore non cessi, e non vengano così precluse le possibilità stesse di riproduzione generale del Capitale. Questa ripartizione, vista come fumo negli occhi dai capitalisti ruspanti della Padania verdastra, e molto benevolmente dai vecchi volponi del capitalismo rosé, ha sempre rappresentato un conto sociale pagato poco dall'industria e molto da Pantalone, conto finalizzato al sostegno dei consumi, non tanto al Sud quanto in tutte le aree senza industria e servizi ben presenti anche al Nord e al Centro, a favore dell'industria del Nord. Persino una comune enciclopedia recita alla voce specifica:
"L'intervento della Cassa tendeva a diventare sostitutivo anziché aggiuntivo rispetto alla spesa ordinaria; i suoi effetti favorivano assai più la ripresa industriale del Nord del paese, dilatando la capacità di assorbimento del mercato meridionale, che non la rinascita del Mezzogiorno; le condizioni di preindustrializzazione che dovevano risultare dalla realizzazione delle opere pubbliche, stentavano a divenire operative" (48).
Apparentemente, come si può notare dai commenti degli interessati, il Nordest può fare a meno del mercato nazionale, dato che ha sufficienti sbocchi sul mercato estero. Infatti spedisce più della metà dei suoi prodotti all'estero e la sola provincia di Treviso, con l'1,3% della popolazione, detiene il 18% delle esportazioni nazionali. L'interscambio con l'area del Marco è anche strepitoso: più del 50% delle esportazioni totali del Nordest e quasi il 70% delle sue esportazioni verso l'Europa. Ma nessun distretto industriale può permettersi di affidarsi alla giungla del mercato mondiale senza coprirsi le spalle con lo Stato nazionale, l'unico in grado di presentarsi sul mercato mondiale con un'autorità politica. Se possiamo affermare che vi sono condizioni di sviluppo peculiari nel Nordest, ciò non significa che questo si possa permettere uno sviluppo "inventato" e uscire dal quadro generale di sviluppo capitalistico comune a tante altre aree sparse per il mondo. E' vero che le cifre "asiatiche" delle esportazioni impressionano, ma bisogna ricordare che il 95% dell'industria italiana esporta in qualche misura e che altri distretti, specie nel settore tessile, calzaturiero e della meccanica di precisione, esportano anche di più di quelli veneti. Come ogni altro distretto industriale, sia irlandese o cinese oppure olandese, anche quello veneto (o triveneto) ha bisogno di una politica statale affinché il primo vento di crisi non lo spazzi via secondo i santi criteri del "libero mercato". Da ciò deriva una specie di schizofrenia, di sdoppiamento, dovuta alla contraddizione logica tra potenziale produttivo in grado di raggiungere elevate prestazioni, e potenziale catastrofico legato ai flussi internazionali di capitali e di approvvigionamenti.
"Se continuerà questa situazione e non si realizzeranno le condizioni generali di convergenza del sistema Italia sui caratteri salienti e sulle esigenze del sistema Nordest, sarà quest'ultimo che, molto prima di quanto si possa prevedere, entrerà in crisi e perderà la sua capacità di restare agganciato al convoglio europeo e all'area del Marco. L'area danubiano-adriatica è l'epicentro della nuova Europa in tutti i sensi. Il protagonismo delle regioni che la formano ne è un ingrediente essenziale" (49).
L'area del Nordest non può fare a meno di seguire l'inesorabile corso del suo ulteriore sviluppo legato a fattori interni ed esterni. Non può fare a meno, perciò, di marciare verso la futura ulteriore concentrazione e, soprattutto, centralizzazione. Ciò comporterà per la generalità dei piccoli e medi imprenditori una concorrenza serrata, l'insicurezza per l'accesso al credito, per il mantenimento delle quote di mercato e perciò per la sopravvivenza delle proprie attività.
S'infiltreranno fra le nostre file peggio che mai
Lo Stato italiano è il più moderno del mondo dal punto di vista della degenerazione politica dovuta alla millenaria maturità del capitalismo peninsulare. Esso continuerà a ripartire plusvalore nella società in forme riciclate, ma non potrà fare a meno di favorire la concentrazione e la centralizzazione, salvo ogni tanto agire affinché la tendenza naturale del capitalismo al monopolio non soffochi l'economia. Per la miriade di capitalisti ruspanti, tanto numerosi che è difficile capire come lo Stato li sopporti, è pericolosa soprattutto la centralizzazione, che sfugge ai provvedimenti antimonopolistici dei governi. Avvenendo in genere senza che il capitale totale si accresca, essa facilita il controllo su varie attività, anche disparate, a favore di pochi capitalisti e a discapito di molti. Diventa difficile, in caso di controllo delle holding, seguire la trama delle partecipazioni dentro gli incastri a scatole cinesi, e può darsi benissimo che attività disparate sparse su vasti territori facciano capo ad un unico capitale. Il capitalismo italiano è molto meno disperso di quanto normalmente si crede.
Si verificherà una situazione per cui molti capitalisti si troveranno a temere per la possibilità di conservazione dei risultati raggiunti e questo si ripercuoterà anche sul resto della popolazione. Saranno quindi probabilmente esasperate le tendenze della piccola e media borghesia a darsi parole d'ordine che abbiano una parvenza di dignità politica. Da questo punto di vista già si intravede una parte dell'intellighenzia schierata nel preparare piattaforme programmatiche, confermando che, come dice Marx, "la piccola borghesia sarà parte integrante di tutte le rivoluzioni che si stanno preparando". Purtroppo, e proprio per questo, non riusciremo a togliercela tanto facilmente dai piedi e s'infiltrerà anche tra le nostre file, urlando roboanti fesserie sulla teoria, sulla tattica e in genere sulla difesa di qualche spazio all'interno di questa società.
Dallo stato nazionale allo stato liberale
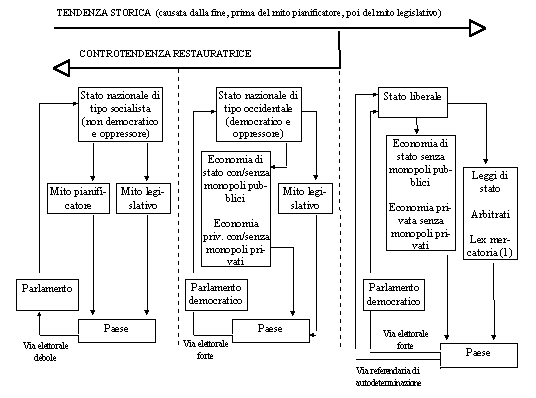 (1) La Lex Mercatoria è "quel corpo di regole ed istituti
concernenti il commercio internazionale comunemente applicati dai mercatores
nella consapevolezza che si tratti di regulae iuris o, almeno, che gli
altri contraenti si comporteranno osservando le stesse regole [...] La Lex
Mercatoria costituisce diritto positivo; infatti è percepita ed applicata come
un corpo di norme giuridiche dalla comunità internazionale dei 'mercanti' ed è
riconosciuta dagli organi legislativi e giurisdizionali degli Stati come fonte
di un ordinamento autonomo" (Aldo Frignani, Il contratto
Internazionale, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico
dell'economia, vol. XII, ed. CEDAM).
(1) La Lex Mercatoria è "quel corpo di regole ed istituti
concernenti il commercio internazionale comunemente applicati dai mercatores
nella consapevolezza che si tratti di regulae iuris o, almeno, che gli
altri contraenti si comporteranno osservando le stesse regole [...] La Lex
Mercatoria costituisce diritto positivo; infatti è percepita ed applicata come
un corpo di norme giuridiche dalla comunità internazionale dei 'mercanti' ed è
riconosciuta dagli organi legislativi e giurisdizionali degli Stati come fonte
di un ordinamento autonomo" (Aldo Frignani, Il contratto
Internazionale, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico
dell'economia, vol. XII, ed. CEDAM).La visione proudhoniana delle non-classi è ottimamente rappresentata nello schema leghista che riproduciamo dall'editoriale de La Padania del 28 marzo 1997 "La via allo stato liberale". La successione completamente antistorica dovuta alla visione piccolo-borghese è evidente: in primo luogo lo schema leghista si limita alla fase di decadenza del capitalismo e vi immette arbitrariamente elementi precapitalistici in posizione predominante (elementi di non separazione dell'individuo dalla vita sociale e quindi tipici di un'epoca in cui non v'era ancora separazione totale dell'uomo dal suo prodotto); in secondo luogo, anche se le tre fasi fossero all'interno del capitalismo, lo schema colloca comunque la democrazia mercantile dopo il capitalismo di stato (fascismo e stalinismo), mentre quest'ultimo è la vera forma "progressista".
Lo sviluppo storico reale
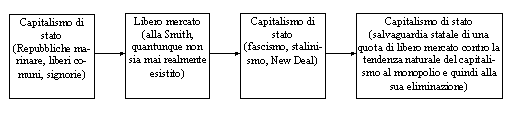
Nel nostro schema il capitalismo di stato non è finito col New Deal, col fascismo e con lo stalinismo, ma si riproduce nella forma liberal-democratica proprio per evitare il suicidio implicito nella massima concentrazione cui non si contrapponesse la vigilanza dello Stato per evitare l'espropriazione di ogni capitalista non monopolista o comunque non abbastanza potente.
Note
(35) In Olanda, Irlanda, Malesia e Singapore sono state costruite infrastrutture imponenti intorno a distretti che hanno attirato capitali internazionali, ma sempre a carico dello Stato. La piccola Hong Kong ha dovuto varare il più gigantesco programma di lavori infrastrutturali mai intrapreso al mondo per non perdere la sua funzione dopo l'iglobamento nella Cina, la quale a sua volta sta facendo lo stesso. Il solo potenziamento del traffico aeroportuale e dei servizi collegati prevede un'isola artificiale di 1.300 ettari, le strutture dell'aeroporto, due ponti sospesi sul mare e due gallerie sottomarine sotto il porto navale. Siccome i capitali non aspettano, L'Airport Core Program di Hong Kong è stato concepito, approvato, finanziato (36.000 miliardi di lire), appaltato e costruito in soli sette anni. L'interessante (a prescindere dalla follia capitalistica e dallo spreco che essa comporta) realizzazione tecnica di tutto ciò è riassunta in "La costruzione di una nuova porta per la Cina", Le Scienze n. 354, febbraio 1998, numero speciale sulle costruzioni infrastrutturali giganti. In Italia, le dorsali di comunicazione progettate per il triangolo industriale, i valichi di frontiera e il polo Venezia-Trieste, vennero poi sviluppate verso il Sud in un deserto infrastrutturale. Esse sono presto diventate obsolete in relazione ai nuovi distretti e il solo riassetto ferroviario comporterebbe la spesa di almeno 300.000 miliardi. "Il costo di produzione dei prodotti distrettuali tendeva a diminuire, mentre il loro costo di trasporto tendeva a crescere. Uno fra i risultati fu la diffusione dei contratti franco fabbrica" che ovviamente penalizzavano il produttore (cfr. "Il federalismo e il cappio logistico dei distretti", La Repubblica Affari e Finanza del 23 febbraio 1998).
(36) Se tale partito non è una novità nella storia, certamente oggi la sua presenza è molto più visibile che un tempo, come dimostrano le oscillazioni della politica parlamentare e le crisi dei partiti tradizionali in tutti i maggiori paesi.
(37) Cfr. K. Marx, Il Capitale, Libro I; cfr. anche Elementi dell'economia marxista, sez. V, Capitalismo e potenziamento del lavoro, ed. Programma Comunista, disponibile presso Quad. Int.
(38) Osservatorio della componentistica veicolare, Rapporto 1996, Camera di Commercio di Torino, febbraio 1997. Le cifre riportate prima, come quelle che vengono dopo, provengono tutte dalla stessa fonte.
(39) G. Lorenzoni, Una politica innovativa nelle piccole e medie imprese, Etas Libri, pagg. 45 e segg.
(40) L'export della produzione industriale dei distretti è il 30% di quello totale italiano, compreso il settore automobilistico e il turismo. Il dato è sempre salito anche in presenza di crisi o politiche macroeconomiche e valutarie avverse, ma a favore dei beni strumentali e a scapito dei beni di consumo, quindi a scapito della maggioranza delle imprese (cfr. "L'Italia salvata dai distretti" in La Repubblica Affari e Finanza del 16 febbraio 1998).
(41) La strategia di Benetton non esclude per principio le joint-venture di produzione, ma esse vengono accettate solo in quei paesi dove la legislazione protezionistica è troppo rigida o il trend di crescita delle vendite è insostenibile e bisogna ricorrere alla produzione locale. In Cina, per esempio, finora ha aperto solo negozi (20 in 12 città) e spedisce la merce direttamente dall'Italia. Nonostante il paese sia uno dei massimi produttori mondiali di lane pregiate e telerie di cotone, la Benetton ha censito un suo specifico bacino potenziale di 200 milioni di consumatori, per cui entro pochi anni è prevista l'apertura di uno stabilimento a Shanghai in joint-venture con un'impresa malese oltre a 300 negozi. In India vi sono già uno stabilimento e 70 negozi ("Le sei Cine del signor Benetton", Limes n. 1 del 1995).
(42) "Nordest vicino al Sud, salari più bassi per gli operai", in La Repubblica Affari e Finanza del 12 genn. 1998.
(43) In tutta l'Italia centrale gli addetti ai servizi sono il 70% della popolazione attiva, nell'area di Bologna l'82%. Per confronto, nel Nordovest essi sono il 45,6% e nel Nordest il 45,1%. Nel Mezzogiorno, dove il pubblico impiego è un fattore di stabilità sociale, gli addetti ai servizi sono il 72% (dati per il 1994 dalla Relazione generale sulla situazione economica del paese, Ministero del Tesoro, aprile 1997).
(44) Cfr. la sconfinata pubblicistica sui settori che si potrebbero inserire in quel che definimmo "colcosianesimo industriale". Essi vanno dalle imprese che lavorano a vario titolo nei grandi complessi come gli ospedali, alla ristorazione collettiva; dai sistemi di appalto delle opere pubbliche alle assicurazioni; dai supermercati a tutta la variegata proliferazione di attività raggruppate sotto il nome di no profit.
(45) Mentre scriviamo i sindaci interessati discutono sulla carenza di infrastrutture per i trasporti nel Nordest. Gli assi viari che stanno oggi scoppiando per il troppo traffico dovuto all'alta produzione, erano parte degli interventi dello Stato per favorire le aree depresse della bassa veronese, del Polesine e della fascia submontana. La polemica è alimentata dall'opposta visione che hanno i sostenitori di un ulteriore intervento dello Stato e coloro che invece vorrebbero far da sé.
(46) Nella Relazione generale citata, verifichiamo per il Nordest un tasso di sviluppo del 2% medio annuo a prezzi costanti nella creazione di valore aggiunto nel periodo 1980-94; 1,7% per il Nordovest; 1,9% per il Centro; 1,7% per il Mezzogiorno. Il Veneto da solo ha avuto uno sviluppo del 2,6% medio annuo nello stesso periodo, mentre l'industria friulana nel post-terremoto è cresciuta a tassi cinesi: 6,9% medio annuo.
(47) Per ironia della sorte la Lega bossiana ha preso lo stesso nome del leghismo corporativo territoriale emiliano. Alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue di ispirazione socialista (1886), e poi staliniana, che è di gran lunga la più forte, si aggiunse nel primo dopoguerra la Confederazione Cooperativa Italiana (1919), di ispirazione cattolica. Sciolte nel 1925, esse risorsero nel 1945, quando nacque anche l'Associazione Generale delle Cooperative di ispirazione socialdemocratica. Nel 1946 le cooperative ebbero la loro direzione generale presso il Ministero del Lavoro e con il decentramento regionale diventarono una potenza economica locale, specie in Emilia. Alcune cooperative "rosse" superarono rapidamente i limiti locali e nazionali vincendo appalti e forniture anche all'estero, mentre le cooperative "bianche" si radicarono, manco a dirlo, nel Veneto.
(48) Enciclopedia Europea Garzanti voce Cassa per il Mezzogiorno. Per i meccanismi di storno dei capitali pubblici da parte dell'industria cfr. cap. "Il saccheggio" in Razza padrona di E. Scalfari e G. Turani, Feltrinelli pag. 353.
(49) "Le ragioni delle regioni: a che serve il Nordest" Limes n. 3/96, p. 103.


 n+1
n+1